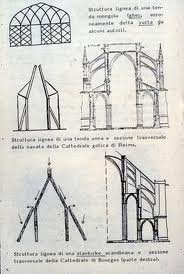|
| motonave Hubertus al lago di Resia |
"Se vuoi viaggiare veloce, viaggia da solo. Ma se vuoi andare lontano, viaggia in compagnia"
Visualizzazione post con etichetta Val Venosta/ Vinschgau. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Val Venosta/ Vinschgau. Mostra tutti i post
domenica 26 ottobre 2014
Motonave Hubertus al lago di Resia
lunedì 21 luglio 2014
Un gioiello in Val di Roja
 |
| Chiesetta di S. Nicola a Roja: Cristo in mandorla con spade, foto di Raffaella Zito |
sabato 22 febbraio 2014
la Corsa dei Zusseln
Il 27 FEBBRAIO (giovedì grasso) a PRATO DELLO STELVIO in Val Venosta si ripete la
Le vie di Prato allo Stelvio si riempiranno di "ragazzi" di ogni età vestiti di bianco e abbelliti con
fiocchi e fiori di carta colorati ed enormi campanacci.
Alla fine del lungo corteo ci saranno una coppia di contadini, una coppia di servi e dalla coppia "Zoch e Pfott”, che
portano gli attrezzi utilizzati per lavorare i campi.
lunedì 28 ottobre 2013
i "Karrner"
I Karrner
non erano zingari, ma venivano
assimilati a loro. Rappresentano
ancora oggi un capitolo spinoso, non superato, della storia tirolese,
in modo particolare di quella venostana.
Al contrario delle altre vallate sudtirolesi, dove vige il diritto di lascito ad un erede unico (da qui il «maso chiuso»), in Val Venosta era in uso la divisione reale della proprietà. E’ una forma di diritto di successione portata dai coloni alemanni, che, dopo la fondazione dell’abbazia benedettina di Monte Maria nel XII secolo, erano stati chiamati dalla Svevia (alemanna) per popolare la valle. La proprietà fondiaria, già poco redditizia per l’asperità del terreno, venne col tempo frammentata e spezzettata all’inverosimile. La popolazione continuava ad aumentare, le possibilità di lavoro e di guadagno diminuivano, guerre, carestie e l’abbandono dell’attività mineraria fecero il resto. Per sopravvivere, molti venostani dovettero cercare altre vie.
Nacquero così, come conseguenza di povertà estrema, i Karrner. Molti autori tirolesi dell’Ottocento li hanno descritti, spesso con la spocchiosa arroganza, ma anche la invidiosa curiosità che il borghese, sedentario e benestante, mostra verso gli «altri»: famiglie numerose, con tanti bambini cenciosi ed allegri attorno ad un carro che veniva trainato dal padre, dalla madre, dai ragazzi più grandi, alle volte con l’aiuto dell’immancabile cane, raramente di un asino o un mulo. Erano carri a due ruote, sormontati da rami di salice piegati e coperti da un telone: carri simili a quelli dei pionieri del far west che erano la casa, la stanza da letto e la bottega dei Karrner .
Erano, infatti, anche venditori ambulanti. Sui loro carri, pieni zeppi di ogni tipo di merce, trasportavano cesti intrecciati e scope fabbricate durante le soste invernali, grasso per carri e crema da scarpe di propria produzione, e poi frutta, formaggio, aceto e sale, pietre per affilare e chiodi, spazzole e fiammiferi, sapone, bottoni ed elastici, rustiche ceramiche da Brunico («Brauneggergeschirr») e colorate stampe. Smerciavano pure uccelli, raccoglievano e arrostivano castagne e i più fortunati commerciavano in cavalli, frequentando i grandi mercati. Il commercio girovago non era tuttavia l’unica fonte di guadagno. Le donne, esperte in erboristeria, erano ricercate per le loro capacità guaritrici, donne e bambini chiedevano vestiti e cibi in carità, mentre gli uomini erano richiesti come musicisti, con la fisarmonica come strumento principe.
Sulle strade del Sudtirolo si potevano incontrare fino negli anni dopo la seconda guerra mondiale i caratteristici carri dei Karrner.
Essi venivano prevalentemente dall’alta Val Venosta, soprattutto dai paesi di Laces, Tarces, Prato e Stelvio, e si chiamavano Federspiel, Wilhelm, Kuen e Höfer. Di loro rimangono qualche tomba nel cimitero di Laces, alcune opere letterarie sul tema (notevoli i «Korrnrliadr» di Luis Stefan Stecher) e un sottile disagio di non pochi sudtirolesi per questi «zingari di casa nostra»
(Emscuola, i Karrner di Wolftraud de Concini)
Al contrario delle altre vallate sudtirolesi, dove vige il diritto di lascito ad un erede unico (da qui il «maso chiuso»), in Val Venosta era in uso la divisione reale della proprietà. E’ una forma di diritto di successione portata dai coloni alemanni, che, dopo la fondazione dell’abbazia benedettina di Monte Maria nel XII secolo, erano stati chiamati dalla Svevia (alemanna) per popolare la valle. La proprietà fondiaria, già poco redditizia per l’asperità del terreno, venne col tempo frammentata e spezzettata all’inverosimile. La popolazione continuava ad aumentare, le possibilità di lavoro e di guadagno diminuivano, guerre, carestie e l’abbandono dell’attività mineraria fecero il resto. Per sopravvivere, molti venostani dovettero cercare altre vie.
Nacquero così, come conseguenza di povertà estrema, i Karrner. Molti autori tirolesi dell’Ottocento li hanno descritti, spesso con la spocchiosa arroganza, ma anche la invidiosa curiosità che il borghese, sedentario e benestante, mostra verso gli «altri»: famiglie numerose, con tanti bambini cenciosi ed allegri attorno ad un carro che veniva trainato dal padre, dalla madre, dai ragazzi più grandi, alle volte con l’aiuto dell’immancabile cane, raramente di un asino o un mulo. Erano carri a due ruote, sormontati da rami di salice piegati e coperti da un telone: carri simili a quelli dei pionieri del far west che erano la casa, la stanza da letto e la bottega dei Karrner .
Erano, infatti, anche venditori ambulanti. Sui loro carri, pieni zeppi di ogni tipo di merce, trasportavano cesti intrecciati e scope fabbricate durante le soste invernali, grasso per carri e crema da scarpe di propria produzione, e poi frutta, formaggio, aceto e sale, pietre per affilare e chiodi, spazzole e fiammiferi, sapone, bottoni ed elastici, rustiche ceramiche da Brunico («Brauneggergeschirr») e colorate stampe. Smerciavano pure uccelli, raccoglievano e arrostivano castagne e i più fortunati commerciavano in cavalli, frequentando i grandi mercati. Il commercio girovago non era tuttavia l’unica fonte di guadagno. Le donne, esperte in erboristeria, erano ricercate per le loro capacità guaritrici, donne e bambini chiedevano vestiti e cibi in carità, mentre gli uomini erano richiesti come musicisti, con la fisarmonica come strumento principe.
Sulle strade del Sudtirolo si potevano incontrare fino negli anni dopo la seconda guerra mondiale i caratteristici carri dei Karrner.
Essi venivano prevalentemente dall’alta Val Venosta, soprattutto dai paesi di Laces, Tarces, Prato e Stelvio, e si chiamavano Federspiel, Wilhelm, Kuen e Höfer. Di loro rimangono qualche tomba nel cimitero di Laces, alcune opere letterarie sul tema (notevoli i «Korrnrliadr» di Luis Stefan Stecher) e un sottile disagio di non pochi sudtirolesi per questi «zingari di casa nostra»
(Emscuola, i Karrner di Wolftraud de Concini)
martedì 1 ottobre 2013
San Florino: un santo originario della Val Venosta
San Florino o St. Florin viene festeggiato il 17 novembre nella Bassa Engandina, in Valtellina e a Mazia in Val Venosta.
Si narra che fosse figlio di un padre britannico e di una madre ebrea convertita al cristianesimo, che il padre avrebbe conosciuto a Roma durante un pellegrinaggio. La coppia si sarebbe stabilita a Mazia/Matsch in Val Venosta, dove Florin sarebbe nato.
Per la sua educazione i genitori lo affidarono al curato di Remus (attuale Ramosch) Alessandro.
Successivamente Florin divenne parroco di Remus e diede prova di santità e miracoli.
Alla sua morte gli abitanti di Mazia/Matsch avrebbero voluto le sue spoglie per seppellirle nel suo luogo natio, ma gli abitanti di Remus, con un sotterfugio, non le restituirono.
Infatti deposero il corpo di Florin in una semplicissima bara di legno in una fossa del cimitero delpaese. Al di sotto di essa fu collocata un'altra cassa riccamente ornata, contenente semplicemente una bella casula, l’abito proprio del presbitero nella celebrazione dell’Eucaristia. I fedeli di Remus gioirono nel vedere quelli di Matsch partire con la bara vuota ed edificarono allora in ringraziamento una chiesa in onore del loro santo.
Etichette:
Leggende e Santi,
Val Venosta/ Vinschgau
Val Venosta
Con la fine dell'Impero romano e in particolar modo dal 507 in poi la Venosta conobbe un periodo piuttosto turbolento: entrò inizialmente a far parte della provincia della Rezia I, controllata dagli Ostrogoti, e nel 536/537 passò sotto l'influenza dei Franchi. Dall fine del VI secolo è probabile un suo controllo da parte dei Baiuvari, alleati a fase alterne con Longobardi e Franchi. Questi ultimi ripresero il controllo diretto della valle sicuramente dal 788, quando Carlo Magno conquistò il ducato di Baviera.
Durante l'età carolingia ha inizio per la valle un periodo di stabilità politica e di ripresa economica e culturale, durante il quale furono edificate quelle chiese (S. Benedetto a Malles/Mals e San Giovanni a Tubre/Taufers) che hanno reso famosa la Venosta in tutta Europa.
L'interesse dimostrato dai poteri politici nei confronti della valle fu dettato dalla grande importanza che essa rivestiva a livello geografico e politico-strategico: controllare la Venosta significava infatti la sicurezza dell'accesso ai bacini del Reno, del Danubio e dell'Adige ....
(Santuari d'Italia: Trentino Alto Adige. La Venosta dalla preistoria al medioevo:geografia e storia di Stefania Lorandi pag. 125, ed. De Luca Editori d'Arte)
Durante l'età carolingia ha inizio per la valle un periodo di stabilità politica e di ripresa economica e culturale, durante il quale furono edificate quelle chiese (S. Benedetto a Malles/Mals e San Giovanni a Tubre/Taufers) che hanno reso famosa la Venosta in tutta Europa.
L'interesse dimostrato dai poteri politici nei confronti della valle fu dettato dalla grande importanza che essa rivestiva a livello geografico e politico-strategico: controllare la Venosta significava infatti la sicurezza dell'accesso ai bacini del Reno, del Danubio e dell'Adige ....
(Santuari d'Italia: Trentino Alto Adige. La Venosta dalla preistoria al medioevo:geografia e storia di Stefania Lorandi pag. 125, ed. De Luca Editori d'Arte)
lunedì 24 giugno 2013
Jörg Hofer, un artista venostano
Jörg Hofer, uno degli artisti della Val Venosta più famosi a livello internazionale, è nato a Lasa nel 1953 e si sente a casa nelle grandi metropoli del mondo.
L'ex allievo di Max Weiler per i quadri creati nel suo atelier utilizza anche la polvere di marmo del suo paese d'origine: Lasa.
L’atelier del famoso artista venostano si trova all’interno di uno storico granaio in muratura Lasa, progettatto e realizzato dall'architetto Werner Tscholl.
L'ex allievo di Max Weiler per i quadri creati nel suo atelier utilizza anche la polvere di marmo del suo paese d'origine: Lasa.
L’atelier del famoso artista venostano si trova all’interno di uno storico granaio in muratura Lasa, progettatto e realizzato dall'architetto Werner Tscholl.
 |
| Atelier di Hofer |
Etichette:
Altre Visioni,
Lasa/ Laas,
Personaggi,
Val Venosta/ Vinschgau
Il primo wisky italiano? In Val Venosta
Alle porte di Glorenza, nel cubo rosso mattone della distilleria PUNI, viene distillato il primo e unico wisky d'Italia.
I due alambicchi della antica forgeria scozzese A. Forsyth & Sons di Rothes, distillano una particolare miscela di malto e segale, frumento e orzo.
La fermentazione del mosto avvienein cinque botti di larice.
Due sono i principali wisky prodotti dalla distilleria:
- l'Italian Single Malt WHITE, il distillato puro non invecchiato nelle botti, da un profumo fruttato alla pera con retrogusto di orzo, frumento, segale e mandorle amare.
- l'Italian Single Malt RED, invecchiato sei mesi in botti vergini di Marsala, sprigiona note legnose attenuate da aroma di uva e legno speziato.
TGutta la segale utilizzata proviene dalla Val Venosta.
Un connubio tra arte vinicola del sud Italia e artigianato venostano di origine scozzese!
Il whisky matura in parte nei vecchi bunker militari dell'Alta Val Venosta, particolarmente umidi e freschi, e in parte in depositi appositamente costruiti.
I due alambicchi della antica forgeria scozzese A. Forsyth & Sons di Rothes, distillano una particolare miscela di malto e segale, frumento e orzo.
La fermentazione del mosto avvienein cinque botti di larice.
Due sono i principali wisky prodotti dalla distilleria:
- l'Italian Single Malt WHITE, il distillato puro non invecchiato nelle botti, da un profumo fruttato alla pera con retrogusto di orzo, frumento, segale e mandorle amare.
- l'Italian Single Malt RED, invecchiato sei mesi in botti vergini di Marsala, sprigiona note legnose attenuate da aroma di uva e legno speziato.
TGutta la segale utilizzata proviene dalla Val Venosta.
Un connubio tra arte vinicola del sud Italia e artigianato venostano di origine scozzese!
Il whisky matura in parte nei vecchi bunker militari dell'Alta Val Venosta, particolarmente umidi e freschi, e in parte in depositi appositamente costruiti.
 |
| distilleria PUNI, arch. Werner Tscholl |
Etichette:
Curiosità,
Glorenza/ Glurns,
Val Venosta/ Vinschgau
La ferrovia della Val Venosta
A suo tempo la linea ferroviaria della Val venosta fu progettata come parte di un progetto ferroviario che ambiva a collegare l'Inghilterra con le terre d'Oriente passando per Calais e Venezia, poi arenatosi.
Oggi il colorato treno diesel in "stile Alto Adige/Sudtirol" è diventato un vero e proprio marchio.
Il binario lungo 60 km congiunge Malles Venosta con Merano; supera i 700 metri di dislivello e unisce mobilità e qualità della vita.
Oggi il colorato treno diesel in "stile Alto Adige/Sudtirol" è diventato un vero e proprio marchio.
Il binario lungo 60 km congiunge Malles Venosta con Merano; supera i 700 metri di dislivello e unisce mobilità e qualità della vita.
La ferrovia venostana ha trasportato i primi villeggianti, contadini, soldati, frutta da tavola della Val venosta, il marmo bianco di Las e i macchinari per la guerra.
Il 9 giugno 1990 il vecchio treno a diesel fa la sua ultima corsa ma, per fortuna, viene riattivata nel maggio del 2005, dando vita ad un nuovo sistema di mobilità in Alto Adige.
venerdì 21 giugno 2013
domenica 17 marzo 2013
Zusslrennen
 |
| Zussel |
Alla vita portano dei grossi campanacci del peso di circa 20 chili che, con il loro fracasso, dovrebbero scacciare gli spiriti cattivi e il freddo invernale e risvegliare la generosità della terra con i suoi prodotti.
Dietro ai Zusselrennen segue un corteo nuziale che si conclude con un contadino che imita la semina con coriandoli.
 |
sabato 16 marzo 2013
Battaglia della Calva
La battaglia della Calva segnò i destini del Tirolo separando definitivamente l'Engandina e il Tirolo.
Come spesso accade i piccoli popoli nell'intento di realizzare le proprie apirazioni si inseriscono nel gioco delle grandi potenze, che usano senza scrupoli posizioni politiche e geografiche dei piccoli come pedine nel più vasto scacchiere dei contrasti tra potenze avversarie.
La Francia era il grande nemico dell'Impero Austriaco. Aveva come alleati il Papato e la Repubblica di Venezia, entrambi interessati a limitare in Italia il potere imperiale e in particolare quello dei suoi alleati: gli Sforza di Milano.
Gli Engadinesi e gli Svizzeri in generale si trovavano come cuscinetto tra le due grandi potenze potendo chiudere a nord gli Sforza, signori della Lombardia.
Una partita giocata tra grandi ove gli Engadinesi, gelosi della propria territorialità e poco propensi a subire l'imposizione di tasse da parte di Massimiliano I, erano disponibili a una alleanza con la Francia.
Per molti aspetti simili ai Tirolesi non hanno mai condiviso, a differenza di questi, i grandi principi di "Gott, Kaiser und Vaterland". Erano bellicosi e divisi in clan, etnicamente diversi, libertari quanto basta per mantenere la propria identità e soprattutto la propria autonomia finanziaria.
Processo nazionale analogo a quello dei Tirolesi, ma senza l'ala protettrice dell'imperatore, visto solo come opprimente spremitore delle loro risorse. La frattura definitiva stava per consumarsi.
A seguito di una limitata incursione degli Engadinesi in Venosta per affermare una presenza antagonista all'Impero, Massimiliano I organizzò una contro-spedizione punitiva. Le sue truppe percorsero l'Engandina ponendo a ferro e a fuoco i suoi villaggi.
Conscio dell'inevitabile reazione attestò le sue truppe al limite territoriale dei paesi a lui fedeli: Glorenza e Laudes.
Laddove la Val Monastero da Tubre scende verso la Venosta, all'altezza del ponte di Calven, punto nel quale la valle ha un forte restringimento, egli creò un formidabile baluardo di uomini, rinforzando ai lati delle pendici ripide della valle con tronchi e sassi e ponendo presidi.
Come raccontato dal monaco benedettino del vicino convento di Marienberg nel volume "Engadiner Krieg", gli Engadinesi altro non potevano fare che aggirare l'ostacolo. Così nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1499 circa 2000 uomini si avventurarono lungo il percorso descritto.
Saliti da Tubre al Tellajoch, discesero la Arundatal tra i boschi, giungendo sopra l'abitato di Laudes. Le truppe imperiali furono prese alla sprovvista. Chiusi alle spalle dai 2000 Engadinesi e dalel forze discese da Tubre, subirono una tremenda sconfitta. Lo scompiglio fu immenso. Oltre 5000 Tirolesi furono massacrati e il loro sangue arrossò le acque del rio Ram. Incapaci di manovrare nello stretto spazio a disposizione tra la destra orografica del rio e il sovrastante bosco, come si può osservare in una bella carta geografica risalente al 1611 opera di Mathias Burglehner e conservata presso il Museo Civico di Bolzano, gli imperiali subirono il 12 maggio 1499 una delle più dolorose e cocenti sconfitte registratasi sul loto territorio.
Gli Svizzeri dilagarono fino a Silandro, distruggendo Laudes e Glorenza. Massimiliano I pianse sinceramente l'amata città di Glorenza. I confini furono così indelebilmente definiti.
Le successive diversità di religione accentuarono, negli anni, la separazione tra Engadina e Tirolo, chiudendo di fatto i commerci e limitando fortemente i reciproci contatti.
L'Alta Venosta da allora subì un decadimento economico i cui riflessi influirono sul benessere dei suoi abitanti fin quasi ai nostri giorni.
(Renzo Caramaschi, Per malghe e per Rifugi in Alto Adige, Raetia)
Lago d'Upia
Per visitare il bel Lago di Upia ci si deve portare in Val di Mazia (deviazione da Tarces, statale della Val Venosta) e percorrerla sino al maso Glieshof.
Da qui si imbocca la forestale in direzione sud est che risale la Val Upia. Per arrivare al lago si cammina per poco più di 2 ore incontrando la Malga di Upiatal e Remsspitz Upia.
Il lago ha una profondità di 11 metri. E' situato ad una quota di 2552 metri tra le pendici di Punta d'Allitz a sud, la Rems Spitz a ovest, la Cima Upia a Nord, il Monte Alto ad est.
Etichette:
Itinerari ed escursioni,
Val Venosta/ Vinschgau
giovedì 31 gennaio 2013
"Sonnenberg", la steppa della Val Venosta
Il "Sonnenberg" si estende, con una lunghezza compresa tra i 500 e i 700 m., dall'ingresso della Val Senales, a ovest di Naturno, per 40 km sino all'entrata della Val di Mazia al di sotto del comune di Malles.
Solo pochi paesaggi delle Alpi presentano caratteristiche così particolari come il "Sonnenberg" in Val Venosta: sole, vento. acqua, freddo, temperature alte e la fruizione antropica hanno conferito a questo paesaggio un carattere inconfondibile.
I pendii aridi e in parte a strapiombo, le cosiddette "Leiten" o "coste", sono caratterizzate da profondi solchi causati dall'erosione. I fianchi, praticamente privi di vegetazione forestale, lasciano intravedere la struttura del suolo.
Le condizioni stazionali aride e l'influenza dell'uomo (eccessivo pascolamento, prelievo forestale) hanno portato alla formazione di un ambiente naturale particolare.
In queste zone si trovano numerose piante che sopportano bene l'aridità, il cui territorio principale di diffusione si trova nell'Europa orientale.
Vi sono inoltre arbusti resistenti all'aridità come il ginepro, il prugnolo e il crespino o alberi come: l'olmo minore, il ciliegio canino, il pero corvino, muschi e licheni.
Il Sonnenberg si è guadagnato la fama di "isola dele farfalle" della Val Venosta: infatti su questi prati aridi e semi-aridi la densistà di specie è molto elevata (il Macaone, Eudia Pavonia ecc.)
martedì 10 aprile 2012
Maestri comacini: utile, solido, bello
Con la nascita degli stati nazionali e un periodo storico relativamente calmo che va dal XI al XIII secolo, l'architettura si basa sulla costruzione di edifici utili - solidi e belli.
Saranno i "maestri comacini" (forse originari del lago di Como!) che applicheranno questi concetti nelle nuove costruzioni relative all'arte romanica. I maestri comacini risultano menzionati per la prima volta nell'Editto di Rotari (643) ed erano delle maestranze specializzate formate da: muratori, lapicidi, carpentieri, ferraioli, guidati da abili "maestri", che utilizzavano utensili innovativi e tecnologie avanzate per la realizzazione di edifici solidi e durevoli.
Saranno i "maestri comacini" (forse originari del lago di Como!) che applicheranno questi concetti nelle nuove costruzioni relative all'arte romanica. I maestri comacini risultano menzionati per la prima volta nell'Editto di Rotari (643) ed erano delle maestranze specializzate formate da: muratori, lapicidi, carpentieri, ferraioli, guidati da abili "maestri", che utilizzavano utensili innovativi e tecnologie avanzate per la realizzazione di edifici solidi e durevoli.
I "maestri comacini", alle fragili coperture in legno delle costruzioni, specialmente religiose, preferirono le volte in mattone che, essendo più pesanti, imposero la modifica di molte strutture. Le finestre si fecero più strette, fu diminuita l'ampiezza delle navate e degli ambienti in genere; le linee d'intersezione delle volte a crociera furono rinforzate da costoloni col compito di scaricare i pesi delle volte stesse sui cosiddetti piani d'imposta. I pilastri sostituirono spesso le colonne, assumendo forme a croce ovvero volumi più complessi.
L'arte romanica assume in ogni paese caratteristiche particolari; nell'Italia settentrionale - per esempio - si manifestano spesso influenze d'oltralpe, particolarmente germaniche, mentre in quelle dell'Italia centrale, meridionale e della Sicilia, si trovano mescolati elementi di derivazione bizantina e arabo-normanna.
Le forme scultoree trovano suggerimenti soprattutto nel mondo della natura, con motivi vegetali e zoomorfi in genere. Vengono realizzati pergami, cornici mistiformi, ghiere, rosoni, portali, logge, ieratiche teorie di personaggi che invadono, con inesauribile invenzione, le parti principali dell'edificio.
In Alto Adige, oltre alle Colleggiata di San Candido, si trovano chiese e dipinti in Val Venosta!
Opera eccezionale è il Crocefisso che si trova nella vecchia parrocchiale di Gries, a Bolzano, databile fra il XII e il XIII secolo, è di grandi dimensioni, ma articolato armonicamente in ogni sua parte.
A Marienberg, come abbiamo già visto, verso la fine del XII secolo, il ciclo dei dipinti parietali veniva sviluppato secondo motivi di un particolare suggerimento tardo-bizantino. In un analogo contesto troviamo inseriti gli affreschi della cappella di castel Appiano/Eppan, databili intorno al 1180-90. La costruzione religiosa venne consacrata nel 1131, anno in cui Ulrich von Eppan completa la realizzazione del maniero (Hocheppan) .
L'arte romanica assume in ogni paese caratteristiche particolari; nell'Italia settentrionale - per esempio - si manifestano spesso influenze d'oltralpe, particolarmente germaniche, mentre in quelle dell'Italia centrale, meridionale e della Sicilia, si trovano mescolati elementi di derivazione bizantina e arabo-normanna.
Le forme scultoree trovano suggerimenti soprattutto nel mondo della natura, con motivi vegetali e zoomorfi in genere. Vengono realizzati pergami, cornici mistiformi, ghiere, rosoni, portali, logge, ieratiche teorie di personaggi che invadono, con inesauribile invenzione, le parti principali dell'edificio.
In Alto Adige, oltre alle Colleggiata di San Candido, si trovano chiese e dipinti in Val Venosta!
Opera eccezionale è il Crocefisso che si trova nella vecchia parrocchiale di Gries, a Bolzano, databile fra il XII e il XIII secolo, è di grandi dimensioni, ma articolato armonicamente in ogni sua parte.
A Marienberg, come abbiamo già visto, verso la fine del XII secolo, il ciclo dei dipinti parietali veniva sviluppato secondo motivi di un particolare suggerimento tardo-bizantino. In un analogo contesto troviamo inseriti gli affreschi della cappella di castel Appiano/Eppan, databili intorno al 1180-90. La costruzione religiosa venne consacrata nel 1131, anno in cui Ulrich von Eppan completa la realizzazione del maniero (Hocheppan) .
sabato 24 dicembre 2011
Vinschger Paarl

Frate Alois Zoschg dell'Abbazia benedettina di Monte Maria/Marienberg a Burgusio/Burgeis in Val Venosta, dopo secoli ha riscoperta la ricetta del pane nero il "Vinschger Paarl". Viene impastato usando farina di segala e di grano e il suo nome Paarl significa proprio "coppia" e deriva da due panini rotondi che vengono uniti per formare un panino.
Etichette:
Malles/Mals,
Val Venosta/ Vinschgau,
Vini e Gastronomia
mercoledì 14 dicembre 2011
"Scheiterhaufen", dolce di mele ricotta e pane
Ingredienti:
6 panini raffermi
1/2 l di latte
3-4 mele
250 g di ricotta magra
3 uova
150 g di zucchero
50 g di uvetta
1/2 chucchiaino di cannella
una presa di sale
un bicchierino di rum
50 g di burro
1) Tagliare il pane a fette e innaffiarlo di latte caldo. Lasciarlo imbevere brevemente. Intanto pelare le mele e tagliarle a dadini o grattugiarle grossolanamente.
2) Dividere le uova e mischiare i tuorli con ricotta e zucchero. Mescolare l'impasto di ricotta con l'uvetta, le mele a pezzettini e la cannella e unirlo mescolando al pane ammollato.
3) Montare a neve fissa gli albumi con un presa di sale e incorporarli delicatamente al composto. Versare in una forma da budino imburrata, spruzzare di rum e decorare con fiocchetti di burro.Cuocere per ca. 1 ora a 160°.
Etichette:
Val Venosta/ Vinschgau,
Vini e Gastronomia
giovedì 13 gennaio 2011
"un uomo senza grembiule blu, è un uomo vestito a metà"
 Il grembiule blu è un elemento indispensabile nell'abbigliamento degli artigiani e contadini sudtirolesi.
Il grembiule blu è un elemento indispensabile nell'abbigliamento degli artigiani e contadini sudtirolesi.Prima del 1880 il grembiule di uomini e donne, padroni o umili mezzadri, era di colore bianco. In seguito si scelse di distinguere il capo per i giorni di lavoro da quello per i giorni di festa, usando il colore blu per i giorni lavorativi.
Maggiormente diffuso è il "grembiule a pettorina" chiamato Schurz, di una tonalità di blu diversa, in base alla zona di provenienza. Molto spesso viene personalizzato con ricami, frasi o il proprio nome.
In val Pusteria, per esempio, il grembiule è di una tonalità di blu molto intensa, nelle valli ladine invece non ha la pettorina.
L'uomo sudtirolese si toglie il grembiule solo nei giorni di festa o per indossare il Tracht, o costume tradizionale.
In val Venosta il grembiule blu è in uso solo fino alla frazione di Burgusio/Burgeis mentre nella zona più vicina alla Svizzera e all'Austria si usa una camicia blu durante il primo giorno di scuola. I bambini del Tirolo ricevono il loro primo grembiule blu durante il primo giorno di scuola.
Etichette:
Curiosità,
Val Pusteria/ Pustertal,
Val Venosta/ Vinschgau
lunedì 6 dicembre 2010
Scheibenschlagen




"Die Scheib, die Scheib in meiner Hand,
ich schlag sie weit ins Land
dass Friede und guete Erntezeit
der Herrgott huier ins verleit"
traduzione: "lancio il disco con le mie mani, lo lancio lontano affinchè il Signore ci accordi pace e un buon raccolto"
Lo Scheibenschlagen è una cerimonia pagana propiziatoria per un buon raccolto. Solitamente questa tradizione si svolge la prima domenica di Quaresima, dove vengono lanciai dischi infuocati verso la valle.
I dischi sono di legno di betulla con un foro centrale tra i 6 e 15 centimetri. Dopo avergli dato fuoco e averli infilati in un ramo di 1-2 metri di nocciolo, i giovani del posto li lanciano - dopo aver formato suggestive forme circolari - prima del distacco del disco arroventato.
La preparazione della cerimonia è lunga e laboriosa: con delle lunghe stanghe si deve costruire la cosiddetta Hexe, la strega. Si tratta di una struttura di 25 metri d'altezza a forma trapezoidale che viene impagliata e che servirà nell'atto finale della festa.
Al tramonto si accendono i falò e sulle braci ardenti si pongono i dischi finchè non saranno inandescenti e pronti per il lancio nel vuoto.
Questa tradizione si è mantenuta soprattutto nella Val Venosta e in particolare nella località di Piavenna/Planol a Malles Venosta
Etichette:
Curiosità,
Malles/Mals,
Val Venosta/ Vinschgau
sabato 16 ottobre 2010
Schwabenkinder
 |
| Schwabenkinder |

Il termine "Schwabenkinder" significa "bambini svevi" ma per molto tempo indicava quei bambini, provenienti da famiglie povere, che venivano comprati (al Kindermarkt) da famiglie abbienti per svolgere i lavori più umili e duri in cambio di:
una coppia di vestiti,
un paio di scarpe,
un cappello e,
talvolta, 1 o 2 monete d'oro.
Il mercato dei bambini (*) più importante si svolgeva nella città di Ravensburg - uno dei maggiori centri commerciali della Germania - che smistava anche 6.000 tra bambine e bambini dai 7 ai 14 anni, ma anche di soli 5 anni !
Molti bambini dell'antico Tirolo (soprattutto della Val Venosta ) attraversavano a piedi i passi di montagna innevati (200 km. in 7 giorni!), con pochi vestiti e scarpe inadatte. Venivano accompagnati da un adulto o, qualche volta, da un prete che aveva anche il compito di gestire l'intera trattativa.
Le bambine e i bambini lavoravano duramente dal 19 marzo (festa di S. Giuseppe) ai primi di novembre (festa di S. Martino) e poi ritornavano a casa.
Fino al 1921 i bambini erano esonerati dall'obbligo della frequenza scolastica per soddisfare le lobby che utilizzavano questa manodopera.
Nel 1908 ci fu una campagna di sensibilizzazione sulla stampa americana che paragonava il mercato dei bambini con il mercato degli schiavi negri.
Questa pratica fu abolita nel 1921!
--
* Nel Sudtirolo, ai primi di febbraio, si svolgeva il Schlenggltag dove si assumevano i braccianti agricoli (bambine e bambini) per la durata di un anno.
Etichette:
Curiosità,
Personaggi,
Val Venosta/ Vinschgau
Iscriviti a:
Post (Atom)